La virtù dell’umiltà
Questo articolo è stato già letto1743 volte!
Umiltà e sobrietà
In noi, quasi mai l’umiltà è questa cosa così limpida e pura, cioè abbassarsi a servire per amore. Essa comporta sempre anche qualcosa di negativo, cioè un rinnegarsi, uno sconfessare ciò che c’è di distorto nelle nostre intenzioni e nelle nostre azioni. Un discendere da noi stessi, prima che andare verso gli altri. Quando è Gesù che “scende”, lo fa da un’altezza reale, oggettiva, perché è il Santo di Dio (cfr. Gv 6,69). Quando invece siamo noi uomini a “scendere”, non ci abbassiamo da un’altezza reale, vera, ma da una pseudo-altezza, da una altezza falsa; ci abbassiamo da un’altezza alla quale ci siamo indebitamente innalzati con l’orgoglio, con la vanità, con l’ira… In noi perciò l’umiltà è sempre anche una virtù “negativa”, che serve a rinnegare qualcosa di cattivo che c’è in noi per cui tendiamo a elevarci al di sopra del prossimo.
In questo senso si dice giustamente che l’umiltà è verità. E’ ripristinare la verità circa noi stessi, è riconoscere che il nostro posto non è stare sopra gli altri, ma sotto. S. Teresa d’Avila ha scritto: “Mi chiedevo una volta perché il Signore ama tanto l’umiltà, e mi venne in mente d’improvviso, senza alcuna mia riflessione, che ciò deve essere perché egli è somma Verità e l’umiltà è verità”.
Anche S. Paolo parla in questi termini dell’umiltà quando dice: “Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso” (Gal 6,3). Per l’Apostolo, si potrebbe dire che l’umiltà è soprattutto sobrietà spirituale, cioè un sentire in modo sobrio, sano, non eccessivo, non esaltato, di se stessi. Dice: “Non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione” (Rm 12,3). Nell’originale greco, la frase suona: “Valutatevi in modo sobrio”. Poco dopo insiste dicendo: “Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi” (Rm 12,16).
Quest’umiltà-sobrietà consiste dunque in un sano realismo che ci permette di essere nella verità dinanzi a Dio. Noi non perseguiamo una verità astratta, non vogliamo essere come lo psicanalista che cerca di portare l’uomo alla verità su di sé, in modo che egli si liberi dai suoi complessi. Noi perseguiamo un’altra verità; la verità che cerchiamo è quella che permette di essere veri davanti a Dio, prima ancora che davanti a se stessi e agli altri, anche se queste cose ne derivano di conseguenza. t scritto di Dio che egli è buono e generoso con l’uomo sincero, ma diventa l’astuto” con il perverso, cioè con chi ha il cuore menzognero (cfr. Sal 18,27). Una cosa Dio esige sopra tutte da chi si accosta a lui: 1a sincerità del cuore” (cfr. Sal 5 1,8)
L’umiltà di Dio
Dicevo che l’umiltà presenta in noi degli aspetti negativi, di rinnegamento, di sacrificio, di croce, proprio perché noi siamo peccatori e abbiamo bisogno di togliere il male che c’è in ogni nostra azione. Ma se è cosi, dove trovare quell’umiltà allo stato puro che non finirà neppure con la morte e che non dice alcuna relazione con il peccato?
La prima risposta che viene spontanea alle labbra è: in Gesù di Nazareth! Ma, a pensarci bene, dobbiamo dire che neppure in lui si trova quell’umiltà allo stato puro, senza alcuna relazione con il peccato. E’ vero infatti che Gesù è l’uomo senza peccato, innocente e santo; è vero che non aveva peccati propri, tuttavia aveva preso su di sé i peccati degli altri uomini e davanti a Dio figurava come “il peccato”. Anche in Gesù, dunque, il suo umiliarsi facendosi obbediente fino alla morte presenta un aspetto di espiazione, cioè di riferimento al peccato. Solo nella seconda venuta, alla fine dei tempi – dice l’epistola agli Ebrei – egli verrà senza più alcuna relazione con il peccato (cfr. Eb 9,28).
Allora – insisto – dove troviamo l’umiltà allo stato puro, quel puro e gratuito abbassarsi a servire per amore? Abbiamo bisogno di arrivare a toccare questo fondamento perché da esso la virtù dell’umiltà trae tutta la sua forza e il suo fascino. La troviamo in Dio, nella Trinità!
C’è una preghiera di S. Francesco d’Assisi, sicuramente autentica (si conserva in Assisi, nella basilica del Santo, scritta di suo pugno); in questa preghiera intitolata “Laudi di Dio Altissimo”, il Poverello intreccia una lode magnifica del Dio Uno e Trino, dicendo tra l’altro: “Tu sei carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei giustizia, tu sei temperanza Quando lessi la prima volta quell’espressione: “Tu sei umiltà”, dissi fra me: “Padre mio S. Francesco, qui non ti capisco più! Forse ti sei lasciato prendere la mano; stavi facendo un elenco delle virtù che si trovano in Dio e vi hai messo dentro anche l’umiltà, senza pensare che l’umiltà è una virtù che non può trovarsi nella Trinità che è tutta
gloria, santità, splendore”. Ma sbagliavo io! Il Santo aveva ragione. Anzi egli ci ha dato, con quelle parole, una delle definizioni più delicate e più sublimi di Dio: Dio è umiltà!
Se umiltà significa scendere da se stessi per amore, Dio è umiltà perché, dalla posizione in cui si trova, non può far altro che scendere; sopra di lui non c’è nulla, perciò egli non può salire, innalzarsi. Quando fa qualcosa “fuori di sé” (ad extra), Dio non può che “abbassarsi”, umiliarsi. Ed è quello che ha sempre fatto dalla creazione del mondo. La storia della salvezza non è che la storia delle successive “umiliazioni” di Dio. Così la vede infatti S. Francesco: “Ecco – scrive – ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine; ogni giorno discende dal seno del Padre sopra l’altare” (FF n. 144); e parlando dell’eucaristia esclama: “Guardate, frati, l’umiltà di Dio!” (FF n. 221).
In seguito, mi sono accorto che questa era stata già un’idea familiare ai Padri della Chiesa. Essi parlavano della synkatábasis di Dio, parola che, tradotta, vuol dire “condiscendenza”, cioè farsi piccolo per potersi accostare all’uomo e scendere al suo livello. S. Giovanni Crisostomo – a cui tale termine era particolarmente caro – dice che già la creazione è un atto della condiscendenza di Dio; che la rivelazione biblica – il fatto che Dio si adatti a balbettare il linguaggio umano – è un atto della condiscendenza di Dio; tale è pure e soprattutto l’Incarnazione.
Ma anche la Pentecoste che stiamo celebrando è un atto di umiltà di Dio. Perché parliamo di “discesa” dello Spirito Santo, se non per lo stesso motivo, e cioè che ogni intervento di Dio a favore dell’uomo è una condiscendenza, un umiliarsi? Nel caso della Pentecoste, lo Spirito Santo si abbassa, assumendo dei poveri segni come sono il fuoco, il vento, le lingue. Si abbassa ad abitare in povere creature di carne facendone il suo tempio.
(Soffermiamoci un istante in preghiera su questa scoperta; ringraziamo il Signore perché ha voluto “uscire” da se stesso per amore nostro, dandoci un meraviglioso esempio di umiltà).
Dopo ciò ho capito perché S. Francesco, nel “Cantico delle creature”, scrive: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”. Uacqua è umile perché, come Dio, dalla posizione in cui si trova non sale mai, ma sempre scende, scende, fino a raggiungere il punto più basso; tende sempre ad occupare l’ultimo posto.
Dio è umiltà: che cosa abbiamo scoperto con ciò? Solo un’idea teologica in più? No, abbiamo scoperto il vero motivo per cui dobbiamo essere umili. Noi dobbiamo essere umili per essere figli del Padre nostro, per “riprendere” dal nostro legittimo Padre. Perché se non siamo umili, noi non riprendiamo dal Padre nostro che è nei cieli, ma da un altro padre ben diverso.
Chi è, nell’universo, colui che ha come suo movimento proprio il salire, il dare la scalata? Chi è colui che dice: “Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il mio trono… mi farò uguale all’Altissimo?” (Is 14,13-14). Non lo nominiamo neppure, per non fargli questo onore nel giorno di Pentecoste, tanto sappiamo bene di chi si tratta. Bisogna dunque essere umili per riprendere dal Padre nostro, altrimenti Gesù deve dire anche a noi quello che diceva ai farisei che si credevano figli di Abramo: ‘”Voi fate le opere di un padre che non è Abramo…” (cfr. Gv 8,38ss).
Umili con chi? L’esercizio dell’umiltà
Adesso possiamo porci la domanda iniziale: “Che cos’è l’umiltà”, ma da un altro punto di vista, molto più profondo. L’umiltà è un atteggiamento verso noi stessi, verso gli altri, o verso Dio? Anni addietro, feci una meditazione sull’umiltà in cui sostenevo che essa non è un atteggiamento verso se stessi o verso gli altri, ma solo verso Dio. Adesso devo correggermi: l’umiltà è tutto questo insieme: è un modo di stare davanti a sé, davanti agli altri e davanti a Dio, pur rimanendo qualcosa di profondamente unitario.
Ho detto sopra che l’umiltà è sorella gemella della carità; come la carità si esprime in due atteggiamenti legati intimamente tra di loro: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso”, così è dell’umiltà. L’umiltà vera consiste nell’essere umili con Dio e umili con il prossimo: le due cose insieme. Non si può essere umili dinanzi a Dio, nella preghiera, se non lo si è con i fratelli. Essere umili davanti a Dio significa essere bambini, essere gli anawin biblici, cioè i poveri che non hanno nessuno su cui appoggiarsi se non Dio solo; significa non confidare né nei carri né nei cavalli, né sulla propria intelligenza, né sulla propria giustizia.
E tutto questo va benissimo. Ma se tu non sei umile con il fratello che vedi, come puoi dire di essere umile con Dio che non vedi? Se tu non lavi i piedi al fratello che vedi, cosa significa il tuo voler lavare i piedi a Dio che non vedi? I piedi di Dio sono i tuoi fratelli! Come si vede, si possono dire dell’umiltà le medesime cose che Giovanni dice della carità (cfr. I Gv 4,20).
Ci sono persone (io sono certamente tra queste), le quali sono capaci di dire di se stesse tutto il male possibile e immaginabile; che, in preghiera, fanno delle autoaccuse di una schiettezza e di un coraggio ammirevoli. Dunque, sono umili davanti a Dio e verso se stessi. Ma appena un fratello accenna a prendere sul serio le loro confessioni, o si azzarda a dire, di essi, una piccola parte di quello che si son detti da soli, sono scintille! Non era vera umiltà la loro. Il vero umile è colui che si guarda in Dio, in lui scopre ciò che è, e poi trasfonde questa verità nel rapporto con i fratelli.
L’umiltà che stiamo scoprendo è un bene che scende dal cielo; essa è quel “dono perfetto che viene dall’alto e discende dal Padre della luce” (cfr. Ge 1, l 7). Non è una pianta che spunta naturalmente sulla nostra terra; il mondo non la conosce. Questa è la sapienza dei Vangelo che confonde la sapienza del mondo. Su questo terreno le due sapienze si scontrano frontalmente, tanto che S. Paolo può dire: “Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente; perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio” (1Cor 3,18ss).
Lo vediamo chiaramente intorno a noi: il mondo, invece di coltivare l’umiltà, esalta l’orgoglio; quando si vuol fare un complimento a qualcuno, si dice che “ha dell’orgoglio”. Il mondo è strutturato sul valore dell’arrivismo, del fare carriera, cioè salire più in alto nella scala sociale. Dalla scuola in su, che cosa si inculca ai giovani se non di fare carriera, di affermarsi al di sopra degli altri, di primeggiare?
Il modo di pensare di Gesù è semplicemente diverso di novanta gradi. E tuttavia bisogna non cadere in errore.
A che cosa mira l’umiltà evangelica? Forse a creare una comunità di rassegnati, di gente inerte, priva di slancio, che non traffica i talenti? Assolutamente no! Il filosofo che affermava questo (Nietzsche), non aveva capito niente del Vangelo. L’umiltà evangelica non significa che tu non devi trafficare i talenti ricevuti; al contrario. La differenza rispetto al mondo è che questi tuoi talenti tu non li impieghi solamente per te stesso, per porti al di sopra degli altri e dominarli, ma li impieghi per il servizio degli altri; non per essere servito, ma per servire. (Continua)
Padre Raniero Cantalamessa

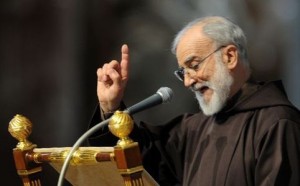
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.